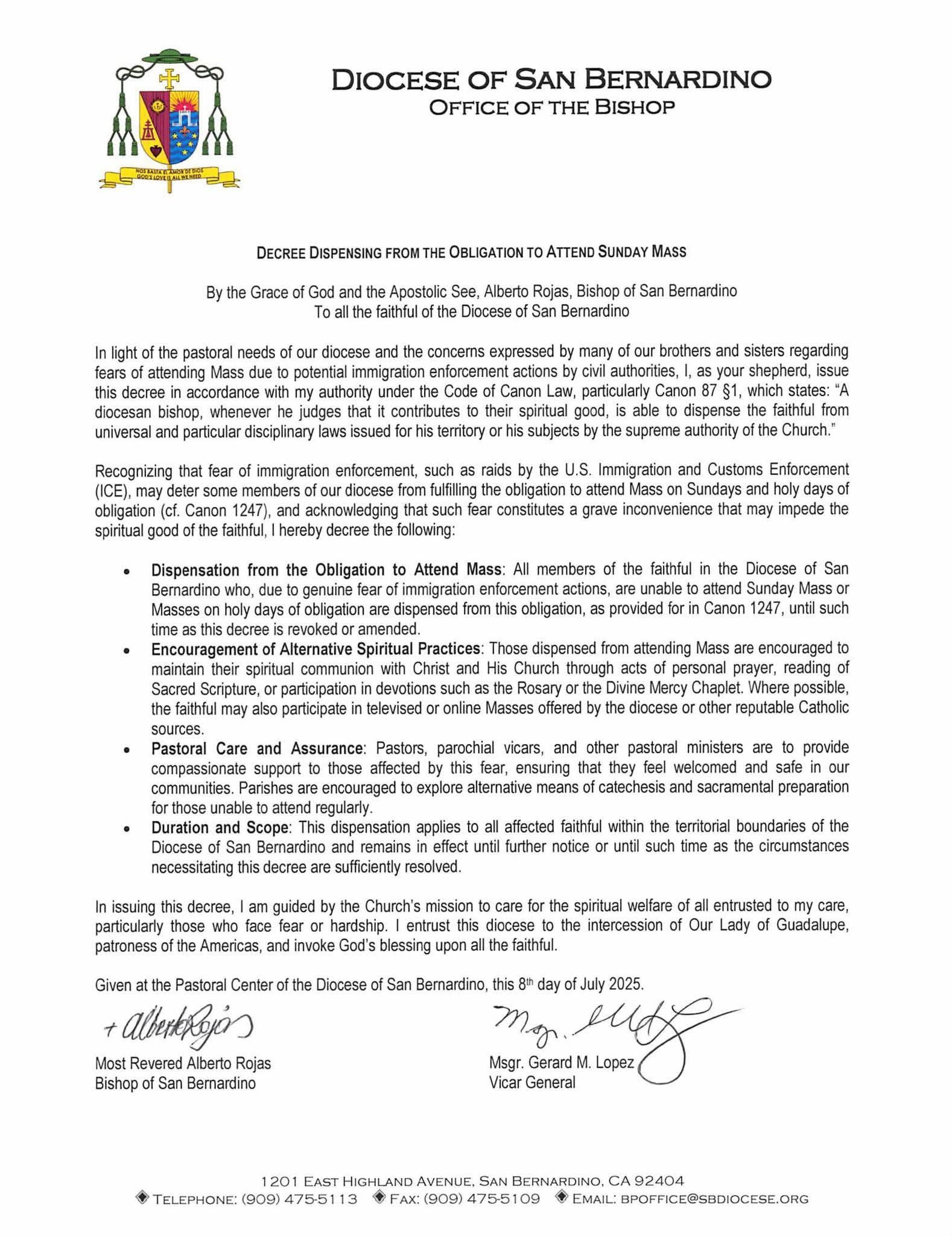Nel cuore della California, il vescovo di San Bernardino, mons. Alberto Rojas, ha emesso l’8 luglio 2025 un decreto che dispensa i fedeli dell’intera diocesi dall’obbligo di partecipare alla Messa domenicale e in occasione delle feste di precetto. La ragione? Il timore, espresso da alcuni immigrati, di essere oggetto di controlli da parte delle autorità civili — in particolare l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) — nei pressi delle chiese o durante le celebrazioni liturgiche.
Sulla carta, il provvedimento si appella al can. 87 §1 del Codice di Diritto Canonico, che consente al vescovo diocesano di dispensare i fedeli dalle leggi disciplinari quando ciò giova al loro bene spirituale. Ma è proprio questo presunto “bene spirituale” a sollevare più di un interrogativo.
Un decreto pastorale o una resa culturale?
La lettera episcopale assume un tono premuroso e apparentemente compassionevole: si riconosce che “la paura di azioni di controllo da parte delle autorità migratorie può impedire ad alcuni fedeli di adempiere all’obbligo domenicale”, e quindi li si dispensa dall’obbligo stesso. Ma in questa logica si cela una profonda ambiguità: se la paura è legata al rischio di espulsione, la premessa implicita è che il fedele sia presente illegalmente sul territorio statunitense. E allora la domanda sorge spontanea: è compito del vescovo legittimare, anche indirettamente, l’irregolarità legale?
Anziché offrire sostegno umano e spirituale per un cammino di regolarizzazione, il decreto sembra normalizzare la condizione di clandestinità, finendo per indebolire l’autorità della legge civile e minare lo stesso legame tra verità e carità evangelica.
Il pericolo della “compassione amministrativa”
Sotto una veste di sollecitudine pastorale, si nasconde una forma pericolosa di paternalismo clericale. Si presume che l’unico modo per tutelare i fedeli sia sospendere un obbligo fondamentale della vita cristiana — la partecipazione alla celebrazione eucaristica — invece di rafforzare il senso di responsabilità personale, la collaborazione con le autorità legittime e l’integrazione nel tessuto civile.
È la vittoria della “compassione amministrativa” sulla verità evangelica: un atteggiamento che elude le questioni più scomode e abdica alla missione profetica della Chiesa. Che ne è, infatti, del diritto degli altri fedeli — magari immigrati regolari o cittadini — di partecipare alla Messa in un clima di sicurezza e legalità? E che ne è della testimonianza pubblica della fede, se essa viene subordinata alla paura dell’autorità civile?
Il rischio di favorire l’illegalità
Non si tratta, in questo caso, di sminuire le sofferenze di tanti migranti — spesso esposti a dinamiche profondamente ingiuste e disumane — né di invocare un’obbedienza cieca alle autorità civili. Ma va riconosciuto con chiarezza che la giustizia, anche quella sociale, non può essere perseguita attraverso deroghe indistinte o indulgenze collettive. Una dispensa di questo genere rischia di tradursi, nei fatti, in un incoraggiamento alla permanenza irregolare, finendo per alimentare un sistema già minato da narrazioni identitarie esasperate e da una crescente erosione della reciproca collaborazione e fiducia fra Chiesa Cattolica e Stato. Documenti come questo assumono inevitabilmente una valenza politica e, in quanto tali, sollevano interrogativi sulla loro opportunità. È del tutto fuori luogo che un vescovo si arroghi il compito di intervenire in modo così diretto nel dibattito pubblico, facendo passare per atto pastorale ciò che in realtà si configura come una presa di posizione ideologica. Se si ritiene che una legge sia ingiusta, la via da seguire non è quella della legittimazione implicita della disobbedienza, ma l’uso degli strumenti che l’ordinamento democratico prevede: il confronto politico, il ricorso giuridico, la mobilitazione civile. La Chiesa non può e non deve diventare un paravento per chi rifiuta la legge mentre continua a invocare i suoi benefici.
Invece di incoraggiare soluzioni comunitarie, reti di solidarietà, forme creative di accompagnamento e inserimento, il vescovo sembra rassegnarsi a una logica del “nascondersi”, quasi a suggerire che il cristiano, pur di non rischiare, possa anche rinunciare all’incontro sacramentale con il Signore.
Una Chiesa che disarma la fede
Il rischio maggiore, tuttavia, non è solo di natura ecclesiologica, ma anche pastorale. Con questo gesto, il vescovo non si limita a piegarsi alle logiche della paura: finisce per legittimarle, assumendo un ruolo che travalica la sua competenza e che ha inevitabili ricadute politiche. In nome di una supposta premura pastorale, si compromette il principio di legalità e si mette a rischio la sicurezza di milioni di fedeli — cittadini, residenti regolari, migranti che hanno rispettato la legge — i quali hanno il diritto di frequentare le celebrazioni liturgiche in un contesto protetto, non esposto all’arbitrio o al rischio di vendette politiche.
Una Chiesa che, anziché aiutare a sanare le fratture sociali, le amplia con decreti disinvolti e messaggi confusi, tradisce la propria missione educativa e perde credibilità proprio agli occhi di coloro che cerca, invano, di proteggere. La dispensa concessa non è un atto di misericordia, ma un grave errore di giudizio. Mentre il mondo cattolico riflette sul senso della testimonianza cristiana in contesti pluralisti e complessi, è lecito domandarsi: quale Chiesa stiamo costruendo, se, di fronte alla fragilità, anziché educare alla verità e alla giustizia, incoraggiamo l’illegalità?
f.S.A.
Silere non possum