Dalla nascita della televisione a oggi, gran parte della società sembra vivere davanti a uno schermo. Un tempo era il televisore al centro del salotto, oggi sono i tablet, i computer e gli smartphone a catturare la nostra attenzione. La tv, in particolare, ha contribuito a formare generazioni di spettatori abituati a consumare immagini e slogan più che a sviluppare un pensiero critico. È questo, forse, l’aspetto che più mi infastidisce di quella “scatola luminosa”: non solo ha diffuso messaggi spesso superficiali o fuorvianti, ma ha anche consolidato l’idea di un dibattito pubblico frammentato, dove la voce dell’altro viene interrotta prima ancora di essere ascoltata.
Nei giorni successivi alla morte di Papa Francesco e durante il conclave, diverse redazioni televisive mi hanno contattato per avere un commento a caldo. Ho scelto di declinare ogni invito: non nutro particolare stima per certi conduttori né per le logiche che regolano quel sistema. Inoltre, pur sapendo che l’Italia resta un Paese anziano, in cui la televisione esercita ancora fascino e influenza, ho sempre preferito rivolgermi soprattutto ai giovani. Essi forse non guardano più la tv, ma vivono comunque immersi in schermi diversi — quelli degli smartphone e dei computer — che generano nuove, ma analoghe, forme di dipendenza e superficialità.
Molti genitori, oggi, usano la televisione come un sedativo domestico: i bambini vengono sistemati davanti a un cartone animato — la Peppa Pig del momento — per tenerli tranquilli e “non disturbarli”. Io stesso ho passato l’infanzia con poco interesse per i libri e soltanto al primo anno di seminario ho scoperto davvero la forza della lettura, inizialmente attraverso testi spirituali e di approfondimento. Più tardi, durante gli studi universitari, ho capito quanto fosse prezioso leggere rispetto al semplice “consumare” immagini sullo schermo. Negli ultimi anni, però, è comparso un medium ancora più invasivo: Internet, che attraverso gli smartphone esercita un’attrazione costante e difficilmente gestibile. Per riuscire a concentrarsi più di qualche minuto, ormai, bisogna letteralmente chiudere il telefono in un cassetto. Mi è rimasta impressa, a questo proposito, un’intervista di qualche tempo fa in cui Gianluca Gazzoli chiedeva a Marco Travaglio perché usasse ancora un vecchio cellulare: la risposta fu chiara, «per non essere continuamente interrotto dalle notifiche».
Ma il problema non è solo personale. Da quando furono inventati i test di intelligenza, un secolo fa, i punteggi medi di QI nel mondo sono costantemente cresciuti: un fenomeno che gli studiosi chiamano effetto Flynn. Eppure, negli ultimi dieci anni, le statistiche internazionali mostrano un’inversione di tendenza: le competenze di alfabetizzazione degli adulti si sono stabilizzate o addirittura calate nella maggior parte dei Paesi OCSE. Un segnale preoccupante, aggravato dal fatto che lo stesso declino si osserva anche tra i più giovani, soprattutto nelle capacità di lettura. Scrivendo sul Financial Times, John Burn-Murdoch lega questo fenomeno alla nascita di una cultura post-alfabetica, in cui i contenuti vengono consumati soprattutto attraverso lo smartphone: immagini e video brevi hanno ormai sostituito i testi lunghi e complessi. Alcune ricerche hanno persino messo in relazione l’uso intensivo dello smartphone con sintomi riconducibili all’A.D.H.D. negli adolescenti, mentre un quarto degli adulti americani intervistati sospetta di soffrirne.
Anche il mondo della scuola riflette questo cambiamento: sempre più raramente si assegnano libri interi da leggere, perché molti studenti non riescono a portarli a termine. Un’eccezione significativa è rappresentata dal professor Alessandro D’Avenia, che ha saputo trasmettere ai suoi studenti una vera passione per la lettura, lontana sia dall’obbligo sterile sia dal compito meccanico del “riassunto delle vacanze” — esercizio che spesso spinge gli alunni a cercare scorciatoie su internet pur di soddisfare le richieste dell’insegnante. Il quadro resta preoccupante: secondo Istat, soltanto il 40,1% degli italiani ha letto almeno un libro nel 2023 per motivi non legati allo studio o al lavoro.
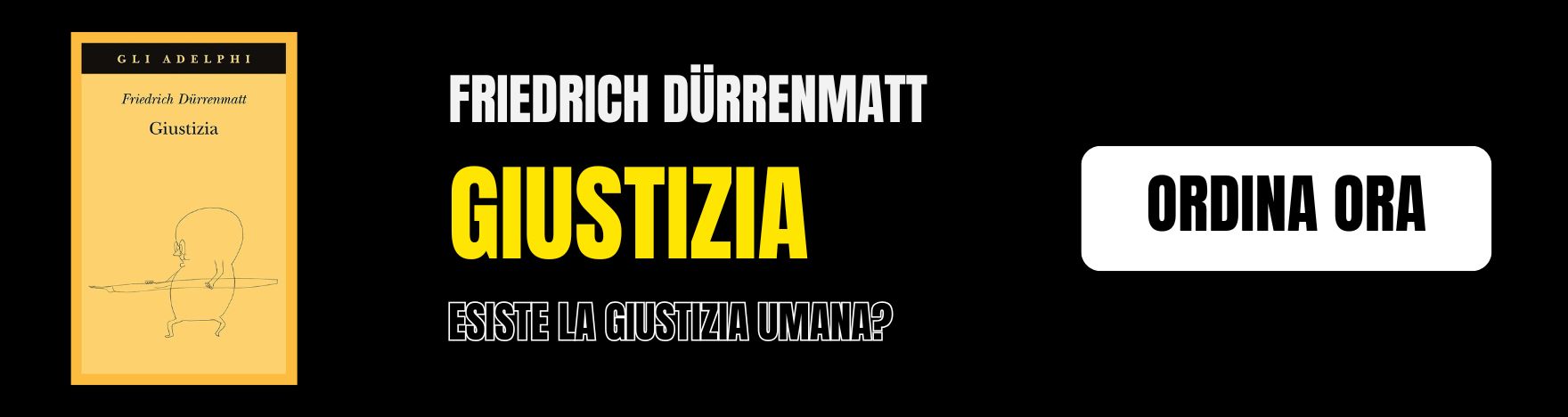
Sempre più si diffonde la consapevolezza che la tecnologia non stia minando soltanto la nostra capacità di concentrarci, ma anche quella di leggere in profondità e ragionare con lucidità. Il rischio è che da questo processo nasca una nuova forma di disuguaglianza. L’analogia con il cibo spazzatura è illuminante: così come gli alimenti ultraprocessati hanno generato, nelle società avanzate, una frattura tra chi dispone di mezzi economici e culturali per seguire una dieta equilibrata e chi, invece, è più esposto all’obesità e alle sue conseguenze, allo stesso modo la “post-alfabetizzazione” potrebbe colpire in modo sproporzionato le fasce più povere della popolazione. La lettura prolungata e complessa non è un’abilità naturale: si acquisisce con esercizio e fatica. Come ha dimostrato la studiosa Maryanne Wolf, diventare “lettori esperti” trasforma letteralmente il cervello: arricchisce il vocabolario, potenzia l’emisfero sinistro analitico, rafforza concentrazione, ragionamento e capacità di pensiero profondo. Da queste competenze sono germogliate conquiste decisive della nostra civiltà: la libertà di parola, la scienza moderna, la democrazia liberale.
L’ambiente digitale, però, ci educa al contrario: notifiche incessanti, contenuti spezzettati, social network costruiti per generare dipendenza. Così il cervello si abitua a saltare da un testo all’altro, a cogliere schemi immediati, ma perde l’allenamento a sostare in un ragionamento complesso. E sempre più spesso la lettura non viene neppure percepita come necessaria. Piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook o YouTube Shorts offrono un flusso incessante di video brevi e accattivanti, mescolati a meme, fake news, titoli acchiappaclick e contenuti generati dall’intelligenza artificiale. È l’equivalente cognitivo del reparto snack al supermercato: irresistibile all’apparenza, ma povero di sostanza.
Qualcuno potrebbe obiettare: “Sta al singolo fare scelte sane, come con il cibo”. Ma, proprio come per l’obesità, i danni cognitivi dei media digitali pesano di più sulle fasce sociali più deboli. Già oggi i bambini poveri passano più tempo davanti agli schermi rispetto ai coetanei benestanti. Uno studio pubblicato su PLOS ONE nel 2017 da Junwen Yang-Huang e colleghi, basato su 3.561 bambini olandesi del progetto Generation R seguiti dai 2 ai 9 anni, ha mostrato che il tempo trascorso davanti alla televisione aumenta costantemente con l’età, passando dal 10% di bambini che guardano più di un’ora al giorno a 2 anni al 70% a 9 anni. I ricercatori hanno rilevato un chiaro divario socioeconomico: i figli di madri con bassa istruzione guardano molta più TV rispetto ai coetanei con madri laureate (24,2% contro 4,7% a 2 anni; 85% contro 61,4% a 9 anni), mentre le differenze legate al reddito familiare sono più marcate nei primi anni e tendono a ridursi con l’età scolare. Lo studio conclude che le disuguaglianze educative nell’uso della televisione compaiono già nella primissima infanzia e si mantengono nel tempo, sottolineando l’importanza di interventi mirati nei primi anni di vita.
In altre parole, compiere “scelte cognitive sane” non è affatto semplice. In un mondo saturo di stimoli rapidi e gratificazioni immediate, la lettura profonda rischia di diventare un privilegio per pochi. Non a caso, tra il 2019 e il 2023 negli Stati Uniti sono nate oltre 250 scuole di ispirazione cristiana, fondate sull’insegnamento dei “grandi libri”. Alcuni genitori arrivano ad assumere babysitter con contratti “no smartphone”, o a iscrivere i figli a scuole Waldorf, dove i dispositivi digitali sono banditi: soluzioni che però hanno costi proibitivi, fino a 34.000 dollari l’anno per una primaria in California.
Anche sul piano istituzionale cresce la consapevolezza: diversi stati americani stanno limitando l’uso degli smartphone in classe, e in Italia il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha esteso il divieto di utilizzo dei cellulari anche alle scuole superiori. Parallelamente, al di fuori della Silicon Valley, si moltiplicano pratiche come il cosiddetto “digiuno da dopamina”: periodi di astinenza da social e videogiochi pensati per allenare l’autocontrollo.
Queste forme di “ascetismo digitale”, tuttavia, restano privilegio per pochi. Le nuove generazioni, che non hanno mai conosciuto un mondo senza smartphone, rischiano di crescere in una società sempre più spaccata: da un lato una minoranza capace di concentrazione e pensiero profondo, dall’altro una maggioranza “post-alfabetica”. Ma cosa accadrebbe se questa trasformazione si compisse del tutto? Potremmo ritrovarci con un elettorato più tribale che razionale, poco interessato ai fatti o alla memoria storica, incline a lasciarsi guidare dalle emozioni più che dagli argomenti, vulnerabile a teorie bizzarre e complotti. Uno scenario che, in fondo, è già visibile in parte dell’Occidente.
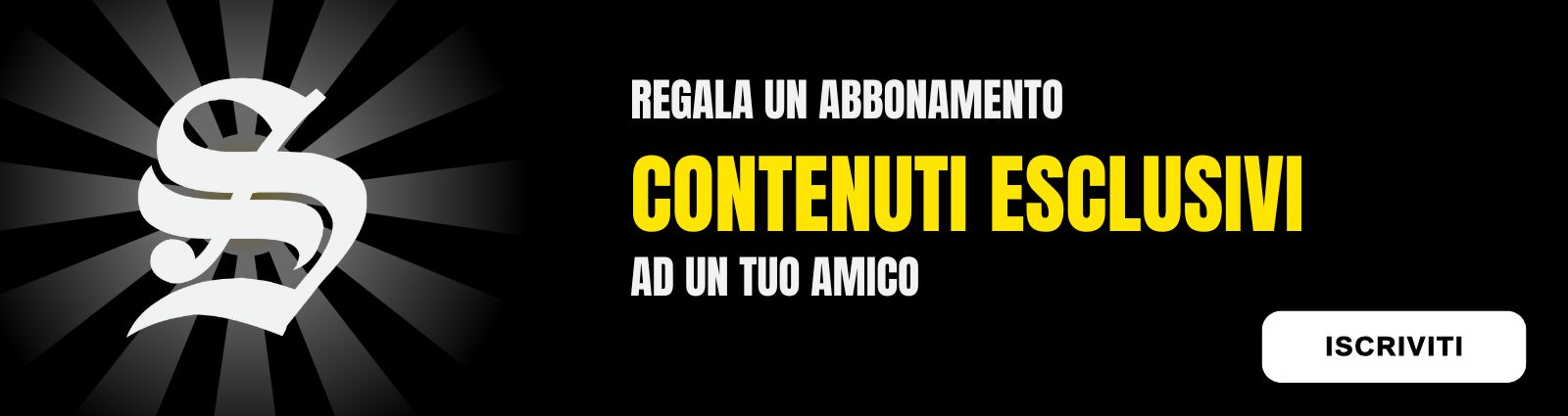
Per i manipolatori, un simile contesto è terreno fertile. Oligarchi e demagoghi, capaci di oscillare dal linguaggio tecnico delle élite al gergo immediato dei meme, possono orientare opinioni e politiche quasi senza opposizione. Non sorprende, allora, che Donald Trump abbia fatto largo uso di questo strumento: dall’immagine che lo ritrae con mitria e ferula nel giorno dell’elezione del Papa, fino alla recente auto-celebrazione sul Monte Rushmore, accanto ai volti scolpiti di Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln.
In un mondo “post-alfabetico” non conta tanto il colore politico, che sia rosso o nero: prevalgono coloro che sanno manipolare i social con più spregiudicatezza che integrità. Chi invece dispone di poco denaro e scarso potere rischia di scivolare nell’invisibilità, senza più voce.